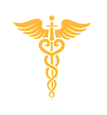Infarto o ansia? La guida definitiva per non farsi prendere... dal panico!
- Doc On Call
- 14 feb 2025
- Tempo di lettura: 3 min
Aggiornamento: 21 feb 2025

Ogni medico prima o poi si imbatte in un paziente che si presenta in pronto soccorso con la frase: "Dottore, mi sento morire!" E puntualmente ci troviamo di fronte al dilemma: infarto acuto o attacco di ansia? Distinguere i due scenari è fondamentale, sia per salvare vite sia per evitare di trasformare il PS in un club di cardiopatici immaginari.
1. Il dolore toracico: il protagonista della scena
L’infarto e la crisi d’ansia hanno entrambi il petto come epicentro del dramma, ma il dolore presenta caratteristiche diverse:
Infarto: dolore oppressivo, retrosternale, spesso descritto come "una morsa" o "un peso enorme sul petto". Può irradiarsi a braccia (soprattutto la sinistra), mandibola, schiena e addome. Dura più di 10 minuti e non migliora con la respirazione. Secondo le linee guida ESC 2023, l’infarto STEMI va trattato con rivascolarizzazione immediata, mentre il NSTEMI necessita di una valutazione del rischio con score come il GRACE.
Ansia: dolore più vago, spesso "pungente" o "a stilettata", localizzato in punti variabili del torace, senza un’irradiazione tipica. Può durare da pochi secondi a ore e tende a migliorare con la distrazione o la respirazione profonda.
STEMI vs. NSTEMI: la battaglia del secolo!
Se il cuore fosse un palcoscenico, STEMI e NSTEMI sarebbero due attori protagonisti… ma con stili diversi!
STEMI = il dramma in prima serata 🎭. Dolore toracico oppressivo, sudorazione, ECG con sopraslivellamento del tratto ST. Il cuore grida “Aiuto! Ho bisogno di un’angioplastica SUBITO!” 🚑 Il trattamento è la riperfusione immediata.
NSTEMI = il thriller sottile 🕵️♂️. Dolore simile, ECG meno eclatante (senza ST sopraslivellato), ma troponina elevata. Il cuore sussurra “Sto soffrendo, ma non così platealmente”. La gestione è più graduale con terapia medica e coronarografia in base al rischio.
2. Le altre cause di dolore toracico: differenziazione diagnostica
Oltre a infarto e ansia, esistono molteplici altre diagnosi che possono presentarsi con dolore toracico:
Patologie cardiovascolari:
Angina pectoris (stabile e instabile)
Dissecazione aortica (dolore lancinante, irradiato alla schiena, ipertensione grave)
Pericardite (dolore pleuritico migliorato sedendosi in avanti, sfregamento pericardico all'auscultazione)
Miocardite (dolore toracico, febbre, segni di infezione virale pregressa)
Patologie polmonari:
Embolia polmonare (dispnea improvvisa, dolore pleuritico, tachicardia, ipossia)
Pneumotorace (dolore acuto, unilaterale, con riduzione del murmure vescicolare)
Polmonite (febbre, tosse produttiva, dolore pleuritico)
Patologie gastrointestinali:
Reflusso gastroesofageo (bruciore retrosternale, peggiora in posizione supina, migliora con antiacidi)
Spasmo esofageo (dolore simile all'angina, non correlato all'attività fisica, miglioramento con nitroglicerina)
Ulcera peptica (dolore epigastrico, migliora con cibo o antiacidi)
Patologie muscoloscheletriche:
Costocondrite (dolore localizzato, riproducibile con la palpazione)
Traumi toracici (storia di trauma recente, dolore alla palpazione)
3. Statistiche e dati epidemiologici
Il dolore toracico rappresenta circa il 5-10% degli accessi in pronto soccorso.
Solo il 15-20% dei pazienti con dolore toracico ha una sindrome coronarica acuta (SCA).
Le patologie gastrointestinali rappresentano circa il 30-40% dei casi di dolore toracico in pronto soccorso.
Le cause muscoloscheletriche sono responsabili del 20-30% dei casi di dolore toracico.
L'embolia polmonare viene diagnosticata in circa il 2-5% dei pazienti con dolore toracico in PS.
La pericardite acuta rappresenta circa il 5% dei casi di dolore toracico non cardiaco.
4. L’elettrocardiogramma: il giudice imparziale
Non sempre l’ECG risolve il dilemma, ma spesso aiuta. Se ci sono alterazioni del tratto ST, onde T invertite o aritmie sospette, è il momento di chiamare la cardiologia. Se l’ECG è perfettamente normale, l'ansia sale... ma solo nel paziente! 😅 Le linee guida ESC suggeriscono l'uso del criterio di Wellens e degli algoritmi ad alta sensibilità per il sospetto di sindrome coronarica acuta.
5. Esami di laboratorio: quando la troponina fa la differenza
Se il dubbio persiste, un prelievo può essere illuminante. La troponina ad alta sensibilità (hs-cTn) è l’esame di riferimento: un valore elevato punta verso un danno miocardico, mentre se resta normale anche dopo diverse ore, il colpevole è probabilmente l’ansia. La regola ESC 0/1h con hs-cTn aiuta nella stratificazione del rischio.
Conclusione: l’importanza di non sottovalutare (ma neanche sopravvalutare)
Sbagliare diagnosi in un senso o nell’altro può avere conseguenze gravi: un infarto scambiato per ansia può essere fatale, mentre un attacco di panico interpretato come infarto può portare a ricoveri inutili e ansia ancora maggiore (anche per il medico!).
👉 Regola d’oro: se il dubbio persiste, meglio trattare il caso con cautela e fare gli accertamenti necessari. Le linee guida AHA/ESC raccomandano una valutazione completa prima di dimettere un paziente con dolore toracico. Nel frattempo, qualche parola rassicurante per il paziente ansioso non fa mai male, mentre per il cardiopatico... beh, meglio avere la nitroglicerina a portata di mano! 🚑
+39 3759027719
The Health Guard S.T.P.